Per questa VI Edizione di IT.A.CÀ siamo emozionati di avere ospite nella nostra p.zza RE ENZO a Bologna il famoso scrittore bolognese WU MING 2 che ama come noi camminare e il viaggio!
DOMENICA 8 GIUGNO > ORE 17.00 L’ALFABETO DELLE ORME: READING -CONCERTO CON WU MING 2 E FRIDA X
Qui di seguito alcuni estratti che ci ha inviato
W. Shakespeare, Racconto d’Inverno, 1611
Le vie maestre non son le mie zone,
troppo vi regnano forca e bastone
ed io per me son troppo spaventato
di finire livido o impiccato
Trotta, trotta sul sentiero
salta allegro il fosso, olà
cuorcontento va leggero
triste cuor non ce la fa.
Hilaire Belloc (1870 – 1953) , Introduzione a The Footpath Way , London, 1911
Guarda un uomo camminare, e guarda di che affare si tratta: come egli rivela il proprio orgoglio, o la determinazione, o la tenacia, o la curiosità, o addirittura il proposito che ne guida l’incedere. Ebbene, tutto questo camminare che tu osservi, è un trucco di straordinaria abilità, tale che se l’animale in questione non fosse noto per conoscerlo bene, tu giureresti che nessuno può addestrarlo per riuscirci. Ecco quel che accade quando un uomo cammina: prima di tutto, egli è in stabile equilibrio, per quanto il suo arco di stabilità sia limitato. Se sta con i piedi ben divaricati, il suo centro di gravità oscilla in un angolo di circa cinque gradi su ogni lato. Ma se oscilla oltre, allora la sua stabilità è perduta, ed egli cade giù. Ma aspetta: egli desidera andare, procedere, raggiungere un punto distante, e invece di andare a quattro zampe, nel qual caso avrebbe stabile equilibrio, che fa? Alza deliberatamente dal suolo uno dei suoi appoggi e manda al diavolo il proprio equilibrio; alla stesso tempo, si sporge un po’ in avanti come per lasciarsi cadere sull’oggetto che desidera raggiungere. Tu non ti accorgi nemmeno che lo fa, non lo sai, perché sei un uomo e la tua ignoranza è simile a quella di un fanciullo che pensa che la sua famiglia sarà per sempre ricca, comoda e sicura. Quel che davvero fai, uomo, quando vuoi arrivare in un posto lontano (è prendiamola come parabola di ogni avventura e di ogni desiderio) è di prenderti un enorme rischio, quello di scapicollarti giù e di rompere qualcosa: alzi un piede da terra e, come se non fosse abbastanza, tu butti volontariamente in avanti il tuo centro di gravità, così che cominci a cadere.
Questo è il primo atto della commedia.
Il secondo atto è che tu controlli la caduta, portando il piede che hai appena sollevato in aria, di nuovo giù sulla terra. Il che, potremmo dire, è già una bella sfida. Lascia lì l’altro piede, riposati, fai un bel respiro e celebra l’impresa. Ma no, nient’affatto. Nel momento in cui sei riuscito a rimettere a terra questo piede ribelle, usi l’impeto della tua prima acrobazia per cominciarne un’altra. Tu sposti il tuo centro di gravità, grazie all’inerzia del tuo andare, ben al di là del piede che ha trovato il suolo, alzi senza curartene l’altro piede, lo lasci oscillare come un pendolo, , e poi controlli la tua seconda caduta nello stesso modo in cui hai controllato la prima; e pure dopo questo secondo, abile successo, non tieni i fermi saldi a terra per riprenderti prima della prossima mossa: vai avanti con la faccenda, porti il centro di gravità altre il piede che sta adesso a terra, muovendo l’altro oltre questo a mo’ di pendolo e bloccando la tua terza catastrofe, e così via; e sei arrivato a fare tutto questo come se fosse la cosa più naturale del mondo.
Non solo sai come farlo, ma lo sai fare in mille modi, così come un vero acrobata non sorprende il suo pubblico solo passeggiando sulla fune, ma pure prendendoci la cena. Sai camminare veloce e svelto, guardandoti le spalle o rilassato, con andatura forzata oppure voltandoti nella direzione che preferisci.
Da tutto questo, puoi vedere che l’uomo è un essere assai rimarchevole, e ciò deve renderti umile, non fiero; perché sei stato progettato a tua insaputa per un destino mirabile, del quale queste mortali stravaganze, così ben tornite e modellate sul tuo essere, non sono altro che simboli.
Walt Whitman, Song of the Open Road, 1856
A piedi e col cuore leggero, prendo la strada aperta.
In piena salute, libero, il mondo davanti a me, il lungo sentiero bruno davanti a me, diretto dove mi pare.
D’ora in poi, non chiedo più buona sorte, io stesso sono buona sorte
D’ora in poi, non mi lamento più, non rimando più, nulla mi serve
Basta con i rimpianti al chiuso, le biblioteche, le critiche querule,
Forte e contento viaggio sulla strada.
La terra – questo mi basta
Non voglio le costellazioni più vicine so che stanno assai bene dove stanno
so che bastano a quelli che appartengono loro
Qui, ancora mi porto dietro i miei vecchi, dolci fardelli,
me li porto, uomini e donne – li porto con me ovunque vado
giuro che mi è impossibile liberarmene
Ne sono riempito, e li riempirò in contraccambio
Tu strada io viaggio e guardo attorno! Credo che tu non sia tutta qui
Credo che ci sia pure qualcosa di nascosto, qui
Qui è la profonda lezione dell’accoglienza, né preferenza né diniego
Il nero con la sua testa cotonata, il criminale, il malato, l’analfabeta non vengono respinti
La nascita, l’affrettarsi dal medico, il vagare del mendicante, il barcollare dell’ubriaco,
il gruppo di operai che sghignazzano, il giovane in fuga, la carrozza del ricco, il damerino,
la coppia clandestina, il mercante mattiniero, il carro funebre, il trasloco in città, il ritorno dalla città,
passano, anch’io passo, ogni cosa passa, nulla può essere interdetto,
vengono accettati, nessuno escluso, mi sono cari, nessuno escluso.
[…]
O strada che io viaggio! O pubblica via! Mi dici
Non mi lasciare?
Mi dici, Non t’avventurare? – se mi lasci sei perduto?
Mi dici, Sono già pronta – ben battuta ed evidente – stai con me?
O pubblica via! Io rispondo che non temo di lasciarti – anche se ti amo
Tu mi esprimi meglio di quanto io sappia esprimere me stesso
Tu sarai per me più della mia poesia
Penso che tutti i compiti eroici vennero concepiti all’aria aperta
Penso che io stesso potrei fermarmi qui e fare miracoli
Penso che mi piacerà tutto quel che incontrerò sulla strada, e che piacerò a chiunque mi vedrà,
Chiunque io vedo, penso sia felice.
Da questo momento, libertà!
Da questo momento, mi dichiaro libero da limiti e rotte immaginarie
Vado dove ho deciso – padrone di me stesso, totale e assoluto
Ascoltando gli altri, considerando bene quel che dicono,
Mi fermo, cerco, ricevo, contemplo
Gentile ma con insopprimibile volontà di spogliarmi dai vincoli che potrebbero trattenermi.
Forza! Chiunque tu sia, cammina con me
Viaggiando con me troverai ciò che non stanca
La terra non stanca mai
La terra è rude, silenziosa, incomprensibile sulle prime,
Non scoraggiarti, tieni duro, ci sono cose divine ben avviluppate
Forza!, non dobbiamo fermarci qui,
per quanto siano dolci questi giacigli, per quanto comode queste dimore
non possiamo rimanere qui
Per quanto riparato questo porto e per quanto calme queste acque,
non possiamo gettar l’ancora qui
Per quanto benvenuta l’ospitalità che ci attornia, ci è concesso riceverne
soltanto per un poco.
Senti, voglio essere onesto con te
Io non offro i vecchi premi lucidati, ma nuovi premi grezzi
Questi sono i giorni che ti attendono:
non ammucchierai quelle che chiamano ricchezze
tu elargirai con mano generosa tutto quello che
guadagni o raggiungi
Tu, appena giunto nella città dov’eri diretto, a fatica riuscirai a sistemarti
in maniera soddisfacente, prima di sentirti chiamare da un irresistibile
richiamo di partenza,
Tu sarai esposto ai sorrisi ironici e ai motteggi di coloro che rimarranno indietro,
Per quanti inviti d’amore tu riceva, potrai rispondere solo con appassionati
baci d’addio
Non dovrai accettare la stretta di coloro che tendono mani verso di te.
Forza! La strada ci è davanti
E’ sicura – l’ho provata – i miei piedi l’hanno provata bene –
non perdere tempo
Lascia che i fogli rimangano sul tavolo senza scritte
e il libro chiuso sulla mensola
Lascia che gli attrezzi rimangano in bottega, lascia che il denaro rimanga non guadagnato
Lascia stare la scuola, non preoccuparti dell’urlo del maestro
Lascia che il predicatore predichi dal suo pulpito, lascia che l’avvocato arringhi la corte e che il giudice esponga la legge
Compagno, ti darò la mano
Ti darò il mio amore, più prezioso del denaro
Ti darò me stesso, prima di prediche o legge
Tu mi darai te stesso? Verrai sulla strada con me?
Resteremo vicini, l’uno all’altro, per tutta la vita?
T. De Quincey, Confessioni di un mangiatore d’oppio, 1822
Non so immaginare vita più felice di questa viandanza, se il tempo è almeno tollerabile, attraverso infinite successioni di bellezza cangiante, e verso sera il cortese benvenuto in una rustica dimora – che pur avendo i lussi di un hotel raffinato, è al tempo stesso libera dagli inevitabili corollari di tali hotel nelle grandi città e nelle stazioni di viaggio – la confusione e il baccano.
Questo genere di vita è un grande piacere, e specialmente per me, che non sono mai del tutto in salute finché non ho fatto esercizio pedestre per quindici miglia al massimo, e otto/dieci almeno. Vivendo così, un uomo si guadagna il piacere quotidiano. Ma quanto gli costa? Circa mezza ghinea al giorno, mentre le mie disponibilità giovanili ammontavano a un terzo. La salute fragrante, la salute che ribolle di fiera passione, che va di pari passo con un simile esercizio, e con l’inalare aria di montagna dal mattino alla sera, presto si trasformò in odioso flagello. Le mance agli inservienti e un letto avrebbero consumato tutta la mia ghinea settimanale. Dunque la mia politica fu, se l’aria autunnale era calda abbastanza, di risparmiare la spesa di un letto e di un cameriere, dormendo tra le felci o le ginestre sopra una collina; e forse con un mantello di peso sufficiente, o un burnus arabo, non sarebbe stato troppo scomodo. Ma dopo, durante il giorno, che razza di fardello da portare! Così, forse, meglio non avere nessun mantello. Tuttavia, per qualche settimana, tentai di portarmi dietro una tenda di tela fatta da me, e non più larga di un normale ombrello: ma per picchettarla in maniera sicura trovai problemi, e nelle notti di vento diventava una compagna movimentata. Avvicinandosi l’inverno, questo sistema di bivacco diventò troppo pericoloso. Uno ancora può bivaccare decentemente, proteggendosi dal vento e dalla pioggia, fino alla fine di Ottobre. Non ci sono, come forse il lettore sa per esperienza, branchi di giaguari, in Galles – e nemmeno puma, né anaconda, né (in generale) dei tagliagole tipo Thugs. Quel che temevo di più, ma forse solo per ignoranza zoologica, era, piuttosto che, mentre il mio volto addormentato era rivolto alle stelle, una delle tante mucche dall’aspetto bramino delle Cambrian Hills, potesse piantarmi la zampa in mezzo alla faccia. Non ipotizzo alcuna precisa ostilità di questa natura, da parte delle mucche gallesi nei confronti delle facce inglesi: ma ovunque osservo nella mente femminile un certo magnifico capriccio, una fiorente esuberanza di quell’attraente ostinazione che temo caratterizzi le nostre care sorelle umane un po’ in tutto il mondo. Contro i tagliagole, avevo l’autorizzazione di Giovenale a non preoccuparmi, visto il vuoto delle mie tasche (cantabit vacuus coram latrone viator). Ma temo che l’autorizzazione di Giovenale non sia sempre valida. Ci sono persone determinate a randellare uno che insiste a scusarsi perché non ha nemmeno un brutto scellino in borsa, senza leggere in questa giovenaliana vacuitas alcun privilegio o esenzione dal tipico destino del viaggiatore che si intromette nella solitudine del ladro.
J. Burroughs, Winter Sunshine, 1875
Il corpo umano è un destriero che va più libero e più lontano sotto un fantino leggero, e il più leggero di tutti i fantini è un cuore felice. Il tuo cuore triste, o cupo, o inacidito o preoccupato, siede pesante sulla sella, e la povera bestia, il corpo, crolla giù dopo un miglio. Davvero, la cosa più pesante del mondo è un cuore pesante. E subito accanto a questo, il più opprimente per il camminatore è un cuore che non sia in perfetto accordo con il corpo – un cuore riluttante o svogliato. Il cavallo e il fantino non devono solo voler andare lungo la stessa via, ma il cavaliere deve guidare la strada e infondere la propria leggerezza e lo slancio al destriero. Qui senza dubbio sta un nostro dilemma e una delle ragioni della decadenza della nobile arte in questo paese. Siamo camminatori svogliati. Non siamo abbastanza innocenti e semplici di cuore per goderci una camminata. Siamo caduti da quello stato di grazia che implica la capacità di godersi una camminata. Un uomo deve investire in cose comuni e alla mano, ed essere contento di un compenso fisso e moderato, se vuole conoscere le benedizioni di un cuore felice e la dolcezza di un cammino sulla terra. Questa è una lezione che l’Americano non ha ancora imparato – la capacità di divertirsi con poco. Egli si aspetta sempre una rendita rapida e straordinaria. Farebbe del pagamento ad usura una legge naturale. Non ha nulla da investire, in una camminata: troppo lenta, troppo a buon mercato. Noi agogniamo ciò che sorprende, l’eccitante, l’esotico, e non riconosciamo le strade degli dei, quando le vediamo. Se dico al mio vicino, “Vieni on me, ho grandi meraviglie da mostrarti”, quello drizza le orecchie e mi segue; ma quando lo porto sulla collina, sotto la piena vampa del sole, o lungo una strada campestre, i nostri passi illuminati dalla luna e dalle stelle, e gli dico, “Guarda, queste sono le meraviglie, questo è il circuito degli dei, questa che ora calpestiamo è una stella del mattino”, egli si sente ingannato, come se gli avessi fatto uno scherzo. Eppure, il distintivo di un maestro della viandanza non è null’altro che questo entusiasmo.
Se non siamo tristi, siamo stanchi, logori, affrettati, scontenti. Ipotechiamo il presente per le promesse del futuro. Se facciamo una camminata, è come se prendessimo una medicina, più o meno con lo stesso gusto e lo stesso scopo; e maggiore è la fatica, maggiore la nostra fiducia negli effetti del trattamento.
Di quei gioiosi pellegrini sulle colline in primavera, di quelle sortite del corpo in inverno, quelle escursioni nello spazio, quando il piede sprizza fuoco ad ogni passo, quando l’aria sa di una nuova e più raffinata mistura, quando accumuliamo forze e felicità via via che procediamo, quando la vista di oggetti sul margine della via e di campi e foreste appaga più dei quadri e di tutta l’arte del mondo – di questi svaghi e intrattenimenti della strada libera, dico, molti di noi sanno davvero poco.
Noto con stupore che nei nostri parchi termali così alla moda, nessuno cammina; che di tutta questa vasta folla di salutisti e amanti dell’aria pura, non se ne trova mai uno per campi o per boschi, o colpevole di essersi trascinato lungo strade di campagna, la polvere sulle scarpe e l’abbronzatura sulle mani e la faccia. Il solo divertimento sembra essere mangiare e vestirsi e sedere di fronte agli hotel a sbirciarsi l’un l’altro. Gli uomini appaiono annoiati, le donne stanche, e tutti quanti sembrano sospirare: “Ossignore! Che dobbiamo fare per essere felici e non di cattivo gusto?”
Leslie Stephen, In praise of walking, 1901
Quando un uomo invecchia, alcuni moralisti gli suggeriscono di trovare consolazione per le crescenti infermità, guardando indietro a una vita ben spesa.
Per parte mia, quando cerco di mettere insieme i ricordi di momenti ben spesi, mi ritrovo a osservare il passato da una prospettiva rovesciata; rovesciata, nel senso che l’accidentale diventa essenziale. Se mi rivolgo all’album intellettuale che la memoria va sempre compilando, trovo che le immagini più nitide che esso contiene sono quelle di vecchie camminate. Altre memorie, di un valore intrinseco immensamente più grande, si fondono in un tutto. Sono più imponenti, ma meno distinte. La memoria di un’amicizia, che ha illuminato un’intera vita, sopravvive non come una serie di accidenti, ma come un’impressione generale delle qualità caratteristiche dell’amico, dovuta al sovrapporsi di innumerevoli immagini dimenticate. Io ricordo lui, non le specifiche conversazioni nelle quali si è rivelato. Le memorie del cammino, invece, riportano tutte luogo e data; sono impigliate a tempi e posti particolari; formano spontaneamente una sorta di calendario, un filo conduttore sul quale altre memorie possono infilarsi. Se mi guardo indietro, mi si presenta una lunga serie di vignette, ognuna a rappresentare una tappa precisa del mio pellegrinaggio terreno, riassunto e incorporato in un cammino. La fatica di scribacchiare libri, fortunatamente non lascia alcuna impressione distinta, e io potrei dimenticarmi di averla mai sopportata; ma l’immagine di una qualche piacevole viandanza, include accidentalmente il riferimento all’incubo del lavoro letterario dal quale essa mi risollevò. Lo scrittore non è che l’appendice casuale del viandante. I miei giorni non sono legati l’uno all’altro dalla “devozione naturale”, ma dall’entusiasmo pedonale. La memoria dei giorni di scuola, se vogliamo affidarci a una tipica rimembranza, generalmente si raggruma intorno a una punizione, o a qualche parola solenne di un maestro spirituale che instilla il germe di un principio guida per la vita. Ma quel che mi viene in mente in maniera più spontanea è la memoria di certe passeggiate, senza impegno, quando potevo dimenticare la grammatica latina, e godere di quel senso delle bellezze della natura che per un bambino risiede in uno stagno infestato dalle pantegane, o un campo reso romantico dalla minaccia di trappole e segnali contro i bracconieri.
Non ho tenuto diari di viaggio, ma potrei ancora raccontare giorno per giorno – i paesaggi che ho contemplato e lo stato dei miei scarponi. Così la viandanza riscatta un pezzetto della vita di un uomo dall’oblio. Gli adepti di altri sport ricordano eventi speciali: quella volta che hai tirato la palla da cricket oltre la tribuna o il granchio che hai catturato mentre la barca girava sotto Barnes Bridge. Ma queste sono memorie di eccezionali momenti di gloria o del contrario, suscettibili di essere macchiati dalla vanità e dallo spirito di competizione. La viandanza è il dimesso filo conduttore di altre memorie, eppure ogni cammino fa storia a sé, ha un suo intreccio definito, con episodi e catastrofi, ma è naturalmente intessuto con tutti i pensieri, le amicizie e gli interessi che formano la base della vita quotidiana.
W. Hazlitt, On going a journey, 1822
Una delle cose più piacevoli del mondo è andare in viaggio, ma a me, piace andare da solo. Posso apprezzare la società dentro una stanza; ma fuori dalle porte la natura è una compagnia sufficiente. D’altronde, non sono mai meno solo di quando sono solo. Non riesco a vedere il senso di camminare e parlare allo stesso tempo. Quando sono in campagna, voglio vegetare come la campagna. Non sono per far la critica delle siepi e delle mandrie nere. Vado fuori dalla città per dimenticarmi la città e tutto quel che contiene. Ci sono quelli che, a tal scopo, vanno nei parchi termali, e si portano dietro la metropoli. Io preferisco avere più spazio di manovra, e meno gravami. Mi piace la solitudine, quando mi ci dedico di proposito, per il gusto della solitudine. L’anima di un viaggio è libertà, perfetta libertà, di pensare, sentire, fare come uno vuole. Andiamo in viaggio principalmente per lasciare indietro noi stessi e ancora di più per privarci degli altri. E’ perché desidero un po’ di respiro per riflettere su argomenti vari, che mi assento dalla città per qualche tempo, senza sentirmi perduto nel momento in cui mi assento da me stesso. Invece di un amico in un calesse, per scambiarsi piacevolezze e variazioni sui soliti argomenti base, per una volta, lasciatemi fare una tregua con l’insolenza. Datemi il cielo blu chiaro sulla testa e l’erba verde sotto i piedi, una strada tortuosa davanti e tre ore di cammino fino a cena – e poi da pensare! Invece di un silenzio imbarazzato, rotto da tentativi d’arguzia e sciocchi luoghi comuni, il mio è quell’indisturbato silenzio del cuore che è l’unica, perfetta eloquenza.
Nessuno ama i giochi di parole, le allitterazioni, le antitesi, gli argomenti e l’analisi più di me, ma alle volte preferisco farne a meno. Forse che quella rosa selvaggia non è dolce, senza un commento? Forse quella margherita non mi salta nel cuore, con il suo mantello smeraldo? Eppure, se dovessi spiegarti le circostanze che me l’hanno resa tanto cara, ti metteresti a ridere. Non avrei fatto meglio, allora, a tenermela per me, e a servirmene per rimuginarci sopra, da qui a quelle rocce laggiù, e da lì ancora avanti, fino all’orizzonte lontano? In tal modo, non potrei essere che un cattivo compagno, e dunque preferisco star da solo.
R. L. Stevenson, Walking Tours, 1876
Non si deve pensare che una viandanza – come alcuni vorrebbero farci credere – sia solo un modo, migliore o peggiore, di vedere un paese.
Ci sono molti modi di contemplare il paesaggio, altrettanto buoni; e nessuno è più vivido, a dispetto di tanti noiosi dilettanti, che da un treno sulla ferrovia. Ma il paesaggio, nella viandanza, è abbastanza accessorio. Colui che appartiene a questa confraternita, non viaggai alla ricerca del pittoresco, ma di certi sentimenti piacevoli – la speranza e lo spirito con i quali la marcia comincia al mattino, e la pace e sazietà spirituale del riposo vespertino. Egli non saprebbe dire se gli dà più diletto mettere lo zaino in spalla oppure toglierlo. L’eccitazione della partenza è la chiave di quella dell’arrivo. Qualunque cosa fa, non è solo un premio in sé stessa, ma verrà premiata ulteriormente nel seguito; e così il piacere porta al piacere, in una catena senza fine. E’ questo quel che così pochi capiscono; i più se ne stanno sempre a poltrire oppure sempre a cinque miglia l’ora; non mettono uno contro l’altro, si preparano tutto il giorno per la sera e tutta la sera per il giorno successivo. E, soprattutto, è qui che il vostro supercamminatore non capisce. Il suo cuore si rivolta contro chi beve il curaçao nei bicchierini da liquore, quando lui può tracannarne un boccale. Egli non può credere che il gusto è più delicato, nella dose ridotta. Egli non può credere che camminare per quella distanza incalcolabile è solo per stupire e violentare sé stesso, e arrivare alla sua locanda, di notte, con una sorta di ghiaccio sopra i cinque sensi e nello spirito una notte oscura e senza stelle. Non è per lui la morbida, luminosa serata del camminatore temperato. Non gli resta nulla di umano se non il bisogno fisico di mettersi a letto con un doppio berretto da notte; e persino la sua pipa, se è uno che fuma, sarà senza incanto né sapore. E’ il destino di un simile individuo di fare il doppio della fatica richiesta per ottenere felicità, e poi mancarla sul più bello. Egli, per farla breve, è l’uomo del proverbio, quello che va più lontano e viaggia peggio.
Ora, per godersela appieno, una viandanza va intrapresa da soli. Se vai in compagnia, o anche solo in coppia, è una viandanza solo di nome; è qualcosa di diverso e più nel genere di un picnic. Una viandanza va fatta da soli, perché devi poterti fermare e riprendere, e seguire quella strada o un’altra, come ti punge vaghezza; e perché devi tenere la tua andatura, e non trottare accanto a un campione di marcia, e nemmeno spezzarla per star dietro a una ragazza. E poi devi essere aperto a tutte le impressioni e lasciare che i tuoi pensieri prendano il colore di quel che vedi. Dovresti essere come un flauto pronto a lasciarsi suonare da ogni vento. Non dovrebbero esserci risate o voci a gomito con te, per scuoterti dal silenzio del mattino. E finché un uomo discute, non può arrendersi a quella sottile intossicazione che deriva dal molto muoversi all’aria aperta, che comincia con una sorta di abbaglio e indolenza del cervello, e termina in una pace che oltrepassa la comprensione.
H. D. Thoreau, Walking, and the wild, 1862
Alcune persone non camminano affatto; altri camminano sulle strade principali, pochi camminano attraverso i campi. Le strade sono fatte per i cavalli e gli uomini d’affari. Io le uso relativamente poco, perché non ho fretta di arrivare ad alcuna taverna o drogheria o stalla o deposito al quale esse conducano. Il paesaggista usa figure umane per indicare una strada. Non potrebbe fare quest’uso della mia figura. Io cammino in una Natura simile a quella che camminarono gli antichi profeti e poeti: Mosé, Omero, Chaucer. Puoi chiamarla America, ma non è l’America: né Amerigo Vespucci, né Colombo né il resto furono i suoi scopritori. Ne esiste un resoconto più vero nella mitologia, che in qualunque altra cosiddetta “Storia d’America” che io abbia mai visto.
Al giorno d’oggi, in questi dintorni, la parte migliore della terra non è proprietà privata; il paesaggio non è posseduto, e il viandante gode di una relativa libertà. Ma potrebbe arrivare il giorno nel quale verrà suddiviso in tanti giardini di piacere – nei quali pochi soltanto potranno avere un piacere ristretto ed esclusivo, – e le recinzioni si moltiplicheranno, e le trappole antifurto e altre macchine inventate per confinare l’uomo sulla pubblica strada, e camminare sulla superficie della terra del Signore significherà violare il terreno di un signore. Godere di qualcosa in maniera esclusiva di solito ti esclude dal vero godimento di essa.
Dunque, cerchiamo di cogliere l’occasione, prima che giunga quel giorno malvagio.
Un giorno di quest’ultimo Novembre ci diede un tramonto rimarchevole.
Io camminavo in un prato, alla sorgente di un piccolo ruscello, quando alla fine il sole, un attimo primo di calare, dopo un giorno grigio freddo, raggiunse uno strato chiaro all’orizzonte, e la più morbida, luminosa luce mattutina, cadde sull’erba asciutta e sui tronchi degli alberi, all’orizzonte opposto, e sulle foglie dei cerri sulla collina, mentre le nostre ombre si allungavano sul prato, verso oriente, come se fossimo gli unici granelli sospesi in quei raggi. Era una luce come mai l’avremmo potuta immaginare un attimo prima, e anche l’aria era tanto serena e calda che nient’altro sarebbe servito per fare di quel prato un paradiso. Quando riflettemmo che quello non era un fenomeno isolato, ma che potrebbe accadere ancora e ancora per un numero infinito di sere, e incoraggiare e rassicurare l’ultimo bimbo che camminasse lì, ci parve ancor più glorioso.
Il sole tramonta su un prato remoto, nessuna casa in vista, con tutta la gloria e lo splendore che profonde sulle città, e forse, come se non fosse mai tramontato prima, – dove non c’è che un falco di palude, a farsi indorare le ali, o soltanto un ratto che guarda fuori dalla tana, e c’è un piccolo ruscello venato di nero in mezzo all’acquitrino, che appena serpeggia, torcendosi lento intorno a un putrido ceppo. Camminiamo in questa luce pura e fulgida, che indora le foglie e l’erba appassita, bagliore così tenero e sereno che io penso di non essermi mai bagnato in un simile diluvio d’oro, senza la minima increspatura o mormorio. Il lato occidentale di ogni albero e di ogni gobba di terra luccicavano come il confine dell’Eliseo, e il sole, alle nostre spalle, sembrava un vaccaro gentile che ci riportasse a casa la sera.
Così pellegriniamo verso la Terra Santa, fino al giorno in cui il sole splenderà più di quanto non abbia mai fatto, fin dentro le nostre menti e i cuori, e accenderà la nostra intera vita con una luce che risveglia, così calda e serena e dorata come su un argine in autunno.
Blog IT.A.CÀ
Sonia Bregoli

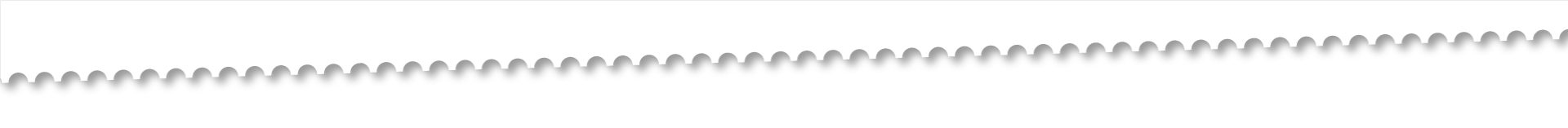












Lascia un Commento
Vuoi partecipare alla discussione?Fornisci il tuo contributo!