Di ritorno dalla Palestina stanotte ho finalmente sognato scene di guerra, di terrore, di violenze. Dico “finalmente” perchè questo è il segno che sto cominciando ad elaborare, inizia cioè la mia lenta digestione psichica dell’aria che ho respirato in questi 15 giorni.
Durante il viaggio ho assorbito, guardato, annusato e ascoltato riempiendomi sempre più di stupore, chiedendomi continuamente “perchè?” e mi arrovellavo morbosamente nel mutismo di chi è assolutamente senza parole. Spiazzata, ecco, mi sentivo proprio spiazzata.
Non che oggi senta di avere risposte ai tanti punti interrogativi ma alcune immagini si sono fissate nella mia memortia e quelle immagini cominciano a parlare. Posso provare allora a scorrerle come un album di fotografie a cui do titoli e didascalie, un album immaginario che muterà, arricchendosi sempre più, col passare dei giorni e, appunto, del mio processo elaborativo.
Immagine 1 “Il polverone di Qalandia”

Qalandia, spesso anche scritto Kalandia, è il grande check-point che separa Gerusalemme da Rahmallah, passaggio obbligato per chi come noi aveva fin dal primo giorno appuntamento lì per noleggiare le automobili che poi ci avrebbero portato in giro per la West Bank. Lo abbiamo attraversato svariate volte, soprattutto di mattina e ogni volta era come scendere nell’inferno: file interminabili di auto e camion che suonano il clacson in continuazione e polvere che si mescola ai gas di scarico a formare una nebbiolina che confonde i confini delle cose che vedi fuori dal finestrino. Non che ci siano meraviglie da vedere…le facce dei soldati con la mitraglietta
a tracolla e un’antenna presumo di radio che sbuca da sopra le spalle; il famoso MURO che venendo da Gerusalemme affianchi per 500 metri e che scorre lì a 30 cm dal tuo naso col suo orribile anonimo cemento, il rotolo di filo spinato in cima e l’immancabile tappeto di rusco a suoi piedi; il grande cartello rosso che avvisa tutti che “oltrepassare quel confine è contrario alle leggi dello stato di israele e pericoloso per la propria incolumità”; passati in WB donne col velo che vagano fra le auto in fila chiedendo 2 soldi con una fotografia in mano, un’improvvisata esposizione di coperte incellofanate messe in vendita (?) allo svincolo fra due file, un immancabile banchetto di frutta impolverata che non comprerei manco morta. Già dopo il terzo attraversamento, una mattina che come al solito eravamo in ritardo su una appuntamento, abbiamo coniato il “mavvaaqqalandia!!” espressione alternativa al famoso “vaffan’culo” da utilizzare soprattutto in un ingorgo stradale di quelli che conosciamo bene anche qua.
Immagine 2 “La donna con 100 mosche sul viso”
Siamo nella Jordan Walley e il giovane Tamar ci accompagna a conoscere alcune famiglie che stanno vivendo sotto l’assedio costante dei coloni e dell’esercito. Arriviamo per una strada sterrata e sassosa in cima a una collinetta brulla. Ci accoglie il capo famiglia, felice di vedere Tamar e di essere oggetto dell’interesse di persone che vengono da lontano per sapere, per vedere, per conoscere. Il colpo d’occhio fin da subito è anche un colpo alla pancia e al cuore: detriti di case, capanne di lamiera stracci appesi a riparare un minimo d’intimità, un ovile con 10 pecore che probabilmente costituiscono l’unica salvezza di questa famiglia composta di una decina di persone fra cui due bambine di pochi anni che dormono in due cassette della frutta imbottite di cuscini. Ci sediamo tutti assieme alla meglio, la drammatica miseria non impedisce di essere ospitali e di offrirci il the o l’immancabile caffè al profumo di cardamomo. Io mi siedo di fianco a una donna della famiglia che attira la mia curiosità. Voglio starle vicino perchè sento subito che lei, con la sua malattia così chiara ai miei occhi, esprime meglio di chiunque altro la follia di questo imbuto del mondo.
Ha un volto tenero coperto di mosche, un’espressione di fragilità negli occhi, abbozza sorrisi mentre risponde borbottando alle voci che le invadono la mente. E’ scalza, forse da sempre perchè ha una crosta nera e spessa sotto i piedi. Le chiedo la mano, ce la stringiamo, mi guarda. Ha indossato dei bracciali di plastica brillante che spiccano nello scuro dello sporco e le faccio segno che la ringrazio per averli indossati in nostro onore. Stiamo vicine mentre siamo tutti lì a chiaccherare con Tamar, prezioso interprete. La sofferenza psichica che diventa malattia grave ha tante origini fra cui il trauma.
Qui la sua malattia ci dice meglio di qualsiasi parola del trauma di vedere la propria casa distrutta 6 volte nell’arco di 15 anni, il suo sguardo da naufrago ci dice di aver visto i soldati e i bulldozer arrivare e distruggere, picchiare, insultare, forse violentare, e le sue voci nella testa ci parlano delle grida di dolore ascoltate fin troppe volte. Questa donna col viso pieno di mosche ha trovato un rifugio, nella follia, appunto, e se ne sta nel suo mondo. Noi oggi siamo lì insieme a lei e alla sua famiglia, penso che per loro questa vicinanza anche solo di una mattina sia molto importante e preziosa. Sicuramente lo è per me, per noi.
Immagine 3 “Olive come se piovessero”.
E’ l’effetto che fa raccogliere le olive nei rami più bassi mentre sopra qualcuno scuote violentemente un grosso ramo. Il telo di plastica steso a terra le fa risuonare come grosse gocce di pioggia. Ti cadono in testa, entrano nelle tasche, nei risvolti dei pantaloni, anche dentro la maglietta. Forse, ho pensato ridendo, uno dei tanti motivi del velo delle donne palestinesi è anche questo… farle scivolare via. Abbiamo passato la nostra prima settimana a racogliere olive con le famiglie di Deyr Istya. In alcuni momenti ho assaporato davvero un’aria di casa: ulivi, profumo di macchia mediterranea, una luce d’estate e i sorrisi che mi hanno ricordato quelli dei vicini di casa (e di vigna) della mia infanzia paesana…solo che la lingua era l’arabo! Il muro elettrificato passava lì a 10 metri e le camionette dei soldati israeliani che proteggono l’insediamento facevano il loro giro ottuso sulla strada subito oltre. Samira ci ha raccontato con poche parole in inglese che gli ulivi della sua famiglia sono al di là dell’insediamento e ormai da anni non riesce ad andarci. Io guardo gli ulivi, la macchia, il muro elettrificato…è tutto immobile, la camionetta passa ogni tanto ma non si vede movimento, agitazione, non c’è l’aperta ostilità che mi sarei aspettata anzi c’è il silenzio…e le telecamere! Mi dicono…”prova a tirare un sasso verso il muro e vedrai che cosa arriva…” . Per carità!

Immagine 4 “Il cielo da sotto la grata a Hebron”.

E’ incredibile ma anche da sotto le grate che proteggono le vie del centro di Hebron il cielo si ostina nel suo azzurro pungente, come a voler vincere sulle umane oscurità. Anche il sole resta limpido e mi chiedo come non voglia fuggire davanti a tanta folle … qui non trovo la parola
, mi arrendo! La municipalità di Hebron ha messo delle reti di protezione sopra alle vie più basse del mercato del centro della
città per proteggere i cittadini arabi costantemente presi di mira da sassi, rifiuti e altro non so che lanciato dai coloni israeliani che negli anni hanno espropriato e occupato i piani più alti delle case. Guardando da sotto oltre al cielo limpido vedo bandiere con la stella di David e sui tetti soldati armati di tutto punto, presumo pronti a sparare se qualcosa non gli torna.
Immagine 5 “Bambina con fucile”.
Questa non è un’immagine di gioco d’infanzia fra i boschi e il fucile non è costruito con la canna dei fiumi. No, qui siamo all’ennesimo chek-point incontrato nel nostro cammino e la bambina è una soldatessa isreliana che controlla i nostri documenti tenendo a tracolla un bagaglio di armamento orribile di ferro e plastica dura che peserà svariati kili. Penso al mal di collo che avrà alla sera quando torna a casa e a come starà concentrata proprio sul dolore fisico per non ascoltare altro di quello che il suo corpo potrebbe dirle a proprosito di quello che fa tutti i santi giorni, a proposito del senso che ha il suo lavoro, a proposito del suo inevitabile contributo alla politica di colonizzazione dei territori palestinesi, a proposito del silenzio che mantiene su quello che vede. Penso anche che mi fa pena.
Immagine 6 “Non ti do la mano”.
Abu Naser ci riceve nel cortile della sua casa, due stanze e un cortile ombreggiato da un telo. Siamo a pochi kilometri a sud di Gerusalemme, al santuario del profeta Samuele che svetta in cima a un colle, affiancato da due splendidi pini marittimi. Abu-Naser ci racconta la storia della sua famiglia della sua casa e del suo villaggio. Fino al 1971 sotto la moschea di Samuele (oggi anche sinagoga) era in piedi un antico villaggio di case in pietra abitato da circa 3 mila persone. Sono arrivati gli israeliani con l’esercito e hanno distrutto tutto. Raso al suolo nel 1971 il villaggio si è ricostruito poche centinaia di metri più in là con quelli che non erano fuggiti, decisi a rimanere in quella che considerano la loro terra. La famiglia di Abu – Naser è una di quelle che resistono. Ci racconta della fatica di costruire due stanze per poi vedersele distruggere poco dopo, ci racconta di come a volte ha reagito ai soprusi chiedendo ai soldati di dentificarsi quando a un chek-point lo hanno arrestato perchè trasportava cibo per le sue bestie. E’ un bell’uomo sui cinquanta con gli occhiali e una barba curata, si percepisce la sua intelligenza e soprattutto la sua determinazione a non soccombere e a far valere quando può i suoi diritti. Ci mostra un malloppo di fotografie e ritagli di giornale che testimoniano le demolizuoni subite, le interviste rilasciate. E’ un uomo che non tace! Oggi sono ancora in duecento i resistenti del profeta Samuele e sopravvivono anche grazie ad aiuti inrernazionali. Gerusalemme è lì a un tiro di schioppo ma a loro è vietato l’ingresso e… faccio la domanda banale… se hanno bisogno di un ospedale? Sapendo già qual’è la risposta: si arriva con un’auto al chek-point, lo attraversi a piedi e di là se va bene c’è l’ambulanza che ti aspetta.
Abu – Naser è già un po’ il nostro eroe quando ci invita ad andare con lui a visitare il santuario di Samuele, a passare davanti ai militari e a visitare la moschea e poi, noi, anche la sinagoga.
Il nostro incontro va concludendosi, siamo sulla strada a fare capannello, le ultime parole, vogliamo salutarlo tutti ed esprimergli il nostro sostegno. I sorrisi e gli sguardi sono di complicità, cominciamo a darci la mano col vigore dei compagni di lotta. E quando si avvicina Katia col suo slancio lui inaspettamente ritira la sua ed esprime con le braccia un gesto che dice “…scusami ma non posso, sei una donna, non mi è consentito, sei impura etc etc”. Abbozza un altro sorriso e se ne va. Io rimango pietrificata. Ma come? Perchè? In poche ore ai nostri occhi uno sconosciuto diventa un mitico paladino della liberazione del popolo palestinese per cadere subito dopo nelle fauci del fondamentalismo più basso…Mi sciolgo dalla pietrificazione e mi incazzo da morire!!!
Immagine 7 “Mamma Roma nella città fantasma”.
Mi sono vista percorrere quella strada come un’Anna Magnani disarmata della sua fierezza. L’angolatura della ripresa era la stessa, il ritmo del passo forse più lento perchè attonito. Spazio vuoto attorno a me che procedo sola…mi sono sentita sola anche se ero con voi, amici. Hebron, Shuhada street, la strada fantasma del centro della città che fu.
Hebron, in arabo Al-Khalil. Dal 1994 l’arteria principale che attraversa il centro della città è un luogo di morte. Non più i negozi e il mercato, i mille odori delle bancarelle, non più la vita di una città araba. Non più. Chek-point e vietato l’accesso!
Nel 1994 un colono ebreo massacra dentro la principale moschea della città 29 fedeli durante la preghiera. Reazione: chek-point e vietato l’accesso. Da allora tutto è fermo così. Chek-point e vietato l’accesso. Vietato alle auto, vietato ai palestinesi anche a piedi, ammessi solo stranieri, israeliani in autobus e militari. Percorrerla, nel suo lieve discendere, è come un cammino da sopravvissuti dopo una catastrofe nucleare. Vuota, polverosa, tende sfrangiate e logore che sbattono per il vento, finestre chiuse di case abbandonate, grate che avvolgono i pochi balconi di case apparentemente abitate, macerie che bloccano gli svincoli e gli immancabili militari armati fino ai denti che passano a piedi incrociando il mio sguardo.
Abdul che non può camminare con noi, che invece possiamo, nella strada principale della sua città, ci aspetta dall’altra parte. Deve fare un giro tortuoso fra controlli e tornelli ma ci diamo appuntamento a fra una mezz’ora ai piedi della moschea. Ci incoraggia anzi a fare questa esperienza del cammino nella terra di nessuno, nella Shuhada Street morta da vent’anni, ed ha ragione.
Bisogna passare sotto quelle buganvillee inselvatichite e piene di polvere che fiancheggiano un marciapiede ormai in disuso, bisogna vederlo l’autobus solitario che porta i bambini israeliani a scuola scortati dai soldati, bisogna respirare quell’aria rarefatta un po’ irreale che mi ricorda il centro de L’Aquila nei mesi e anni dopo il terremoto. Qui il terremoto è un regime odioso di apartheid, una colonizzazione casa per casa, scuola per scuola, strada per strada. Qui il terremoto si ripete da vent’anni tutti i giorni.

Testimonianza dell’esperienza del campo di volontariato internazionale in Palestina organizzato dall’associazione YODA in collaborazione con il GVC di Bologna. Alla sua terza edizione, l’obiettivo del campo è quello di dare la possibilità ai volontari di vivere per due settimane accanto alle famiglie palestinesi durante la raccolta delle olive in ottobre – unico sostentamento economico all’interno dei territori occupati palestinesi. Durante la seconda settimana si fanno incontri con associazioni locali palestinesi e israeliane nelle varie città: Hebron, Ramallah, Gerusalemme, Betlemme, Valle del Giordano, Nablus…
Le foto sono di Katia Monti (Volontaria YODA)
Blog IT.A.CÀ
Rita Lambertini
Volontaria YODA

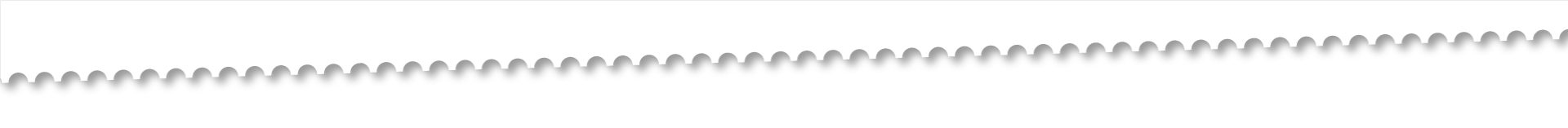












Lascia un Commento
Vuoi partecipare alla discussione?Fornisci il tuo contributo!